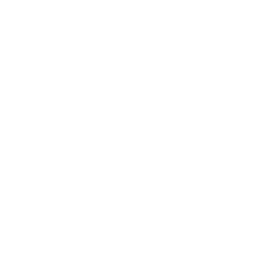Relazione “ragionata e sistematizzata” dell’intervento omonimo tenutosi il 17 aprile 2021, su cortese invito di Massimiliano Polselli, direttore della rivista scientifica Consecutio Temporum, presso l’associazione culturale Conduco un Dialogo, di Maria De Carlo, in occasione dell’evento: “Da corpi elettorali a corpi vaccinali”.
Possiamo considerare l’evento del morire coimplicato nella stessa costituzione dell’essenza dell’esistenza umana. Solo l’uomo, autenticamente, muore, poiché solo all’uomo si fa incontro la morte
nella vita. Certo, noi non incontriamo mai la nostra propria morte per cui, come ebbero a sostenere gli epicurei, è privo di senso il temerla, precisamente in quanto vita e morte sono autoescludentisi quanto l’essere e il non essere: se e finché si dà la vita, se e finché ci siamo, non si dà la morte, non mai incontriamo il nostro morire.
E, nondimeno, noi incontriamo il morire degli altri. Attraverso ciò che non siamo, ovvero attraverso l’altro da noi, la nostra propria morte ci appare. Col suo mostrarsi, ci si fa innanzi, coimplicativamente appunto, ciò che di più caro scopriamo lì e allora di avere, ovvero il nostro esserci, il nostro esistere: solo lì e solo allora iniziamo a temerne la perdita, poiché solo lì e solo allora si apre la possibilità, per noi, per la nostra coscienza, del morire: se una soggettualità non sapesse di dover morire, non temerebbe la morte. Pertanto, attraverso il non-essere e l’altro-da-noi, attraverso ovvero il non-più-esserci-dell’altro-da-noi-che-ancora-siamo, ciò che più ci sta a cuore, ovvero il nostro essere stesso, ci si fa incontro.
Ciò che più ci sta a cuore possiamo definirlo la nostra essenza. Prima infatti di divenire concettualizzata come
eidos o universale di una molteplicità, categoriale a cui compartecipano, per essere ciò che sono, tutte le datità individuali ed empiriche afferentigli, l’essenza è ciò senza la quale non potremmo essere, egualmente ciò che non è accessorio, bensì necessario. Per questo Heidegger può definire l’esserci, il
Dasein (ovvero l’esistenza umana) come quell’ente, nella cui essenza, ne va della propria stessa esistenza (l’interrogazione di senso sul fondamento ontologico naturalmente consegue all’esperienza pre-vissuta del nostro morire attraverso il morire degli altri, ma trova in essa la propria sostanza e origine).
Possiamo dunque definire l’evento della morte come l’evento della Di-partizione originaria (Ur-teilung).
Della di-partizione dunque che separa, da un lato, l’essere dal non essere; dall’altro, il “noi” da ciò che noi non siamo, ebbene, filosoficamente, l’Io dal Non-Io, l’identità dall’alterità, la coerenza dalla contraddittorietà: infatti, noi abbiamo coscienza di essere pienamente noi stessi nell’attimo esatto in cui noi ancora siamo, mentre l’altro da noi non è più.
Essere e Non-Essere, Identità e Alterità, Io e Non-Io, appaiono con l’apparire della morte.
Ma la morte non rappresenta l’evento della di-partizione originaria solo sul piano dell’Essere, dell’Identità e della Soggettualità, bensì anche sul piano del Tempo. La morte è, infatti, la Fine assoluta, e noi esperiamo lo scorrere secondo il prima e il poi (nella definizione che Aristotele dà del Tempo) partendo da questo fondamento di inoltrepassabilità del punto estremo. È provenendo dalla fine che il nostro presente ci si fa incontro: solo chi è destinato alla fine, può avere un futuro; solo chi ha un futuro può avere tempo,
ancora tempo.
Ma, avere un futuro significa anche avere uno Spazio libero o ancor nullo entro il quale il nostro-sopraggiungere-oltre il presente possa trovare dimora, il nostro e, parimenti, di ogni nostro pro-getto. Senza la lacuna libera del futuro, non potremmo progettare alcunché, non avremmo ovvero spazio dis-ponibile per pro-iettare il nostro proprio futuro o il futuro di ogni nostro proponimento.
L’evento estremo della morte, intenso come saturazione assoluta dello Spazio libero o della Potenza, cioè della Possibilità, rappresenta dunque la stessa di-partizione dello Spazio: è l’entelechia dello Spazio.
L’evento della morte, da ultimo, determina dunque l’essenza dell’uomo ascrivendogli i caratteri dell’anticipazione e dell’irreversibilità estrema che tutto retro-possibilizza. L’uomo è quell’ente che, per essenza, ha un Destino, ossia una meta, un orizzonte, un tramonto, un punto escate che, giacché non ulterioriormente pro-cranistabile, consente l’apertura di quella dimensione libera in cui può farsi via via evento l’apparire dell’essere e dell’atto, ovvero di ciò che noi chiamiamo Storia. L’uomo è dunque, egualmente, quell’ente che, per essenza, ha una Storia. Storia e Destino, Essere e Nulla, sono coimplicati nella vicenda dell’Uomo.
Ora, questi caratteri sono direttamente proporzionali, cioè, in linguaggio heideggeriano, variamente autentici o inautentici, quanto più il fondamento della Di-partizione come fondamento originario è pertenuto inconcussibile, saldo: la Verità, diceva Parmenide, ha il cuore non tremante.
Più si tiene ferma la dis-tinzione tra Essere e Nulla, Identità e Alterità, più la di-stanza tra queste antipolarità aumenta, si di-lata o di-lacera. Noi siamo esattamente questo framezzo, questo
Diá, ed esistiamo tanto più autenticamente o coerentemente rispetto al nostro destino, quanto più consentiamo il dis-tendimento del Framezzo, ovvero la libertà per l’evenire della Storia dell’Essere.
Nel primordi dell’uomo, questo framezzo è dis-chiuso solo parzialmente, molto debolmente. L’altro che muore non è destinato al nulla assoluto, non è sottratto irrimediabilmente alle vicende dei presenti, bensì sopravvive in qualche modo nella Comunità, come spirito, come parte del Tutto immanente, come vento o sabbia, o come il risplendere degli astri nel cielo notturno, come “mana” animante gli oggetti.
Questo è il tempo del Mito.
Secondo il pensiero di Emanuele Severino, nel tempo che precedere il sorgere del pensiero filosofico, l’uomo affidava alla narrazione mitica la rassicurazione contro l’angoscia che l’evento della morte gli cagionava. Il Mito è infatti la narrazione che dispiega il senso del Mondo e la sua Origine: raccontando il mondo e il morire nel mondo, si esorcizza la paura attribuendo un significato “cosmico” agli eventi che toccano ogni individuo, singolo che in questo modo acquisisce un posto nel Tutto e in tale acquisizione esorcizza l’inquietudine di un nascere e un nascere privi altrimenti di senso.
Sempre secondo Severino, col crescere della coscienza collettiva o storica, cresce il dubbio circa il fondamento di Verità che il “rimedio” del mito aveva sino ad allora fornito, ebbene, quella rassicurazione delegata alla narrazione cosmogonica del senso dell’accadere delle cose, non basta più all’uomo, e l’uomo stesso va alla ricerca di un sapere che possa “scacciare la paura della morte (questa volta) con Verità” (Eschilo).
Sorge così il sapere incontrovertibile, il sapere che i greci chiamavano episteme e che possiamo tradurre come scienza solo se pensiamo la scienza suprema come scienza dell’ente in quanto ente o meta-fisica.
Nondimeno, l’evocazione del sapere incontrovertibile, apre un solco estremo e insuturabile tra l’essere e il nulla: ecco che la morte diviene coi Greci annichilimento assoluto, irreversibilità perfetta, e dunque la ricerca stessa di maggiore Verità del rimedio esorcizzante parrebbe, apparentemente, rivolgersi contro l’uomo che l’ha evocata, aumentando l’angoscia del morire.
Ma, quella che potrebbe pertanto apparire, se non come una contraddizione, quanto meno come l’evocazione faustiana di un demone (l’episteme) che poi non si è in grado di padroneggiare, è in verità tale solo se non consideriamo che l’episteme o scienza dell’incontraddittorio, del Vero assoluto, consente il fondamento (e il fondamento a punto incontrovertibile e non fideistico o mitico) di quella realtà altra e ulteriore rispetto alla dimensione in cui ha giurisdizione il morire. Coi greci sorge, infatti, anche la divisione platonica di anima e corpo. Il corpo può pure abbandonarsi al morire, ma l’anima è intonsa dalla morte, e non è una fede mitica e contingente ad affermarlo, ma la Verità stessa e il suo sentiero diurno: l’Essere è e non può non Essere. L’anima, ovvero è ciò che pienamente è, è immortale ed eterna epperò non può mai non essere, è sempre.
Nondimeno, giunge anche il tempo in cui l’uomo si accorge (qui rimanendo sempre nella prospettiva di Severino) che l’eterno evocato con incontraddittorietà dall’episteme greca è ciò che più osta all’espansione della volontà: “se gli dei esistessero, io non potrei creare, ma io creo, dunque non esistono dei” (cioè non esistono immutabili), afferma Zarathustra. Il Divenire, ovvero la Volontà, che è ora, nel ribaltamento del platonismo, la realtà pienamente essente (mentre l’eterno essere diviene illusione, “rappresentazione”), si concreta massimamente nella Volontà creatrice dell’uomo e dell’uomo artista, ma, per poterla afferrare, l’uomo deve liberarsi dell’incontrovertibile.
Ecco che il pensiero del nostro tempo elimina progressivamente ogni limite immutabile, per poter dare massimo sfogo alla tecnica, ovvero alla volontà di trasformazione del mondo.
Nel tempo della tecnica, dunque, l’uomo torna a occuparsi della morte (se l’anima e la realtà dell’anima non esistono, se non esiste l’eterno, l’uomo torna preda del Nulla), ma non se ne pre-occupa più poiché affida alla tecnica (che è scienza applicata) il compito di occuparsene. Sorge dunque, nel nostro tempo, l’idea che la scienza, prima o poi, ci libererà dalla morte e dal dolore.
E, nondimeno, per poterlo fare, la tecnica ha dovuto abbandonare la necessità, ovvero, ancora, l’incontraddittorietà della Verità assoluta, figurazione dell’immutabile.
Ecco dunque che, nel momento stesso in cui la tecnica “scaccerà il dolore e la morte”, lo farà senza Verità, per cui non scaccerà il dubbio di averla
veramente scacciata.
Esposta la parabola severiniana dell’evento del morire tra mito, episteme e tecnica, prendiamo solo ancora pochi minuti per evocare, seppur solo per accenni, un’altra parabola, un’altra strada, la strada ovvero dell’Alterità o della Differenza come fondamento.
E lo facciamo tornando al dire della Di-partizione come evento originario.
Che cosa si di-partisce in principio? Ebbene, se abbiamo affermato che la Di-partizione è l’Originario per l’Uomo, ovvero che noi siamo
da quando ci percepiamo come individualità, ovvero dal sorgere dell’autocoscienza, e che questo sorgere, distinguente me dall’altro da me, l’Io dal Non-Io, è coimplicato nella distinzione ontologica (Io sono Io nell’esserci come non essere l’altro che non è più), allora possiamo adesso affermare che ciò che si di-partisce in principio è la Di-partizione stessa, ovvero che la Di-partizione è a-bissale o, egualmente, che il fondamento della Di-partizione è il
nulla del fondamento, il nulla dell’essere, ovvero che il Non-ente stesso è il contenuto della posizione o entificazione del Principio.
Noi, infatti, possiamo chiamare “spazio libero e s-confinato” ciò che si estende al di là di un confine, solo allorquando tracciamo il confine medesimo. Ante la di-partizione, non c’è alcuno spazio libero, alcun esterno, neppure l’indistinto o l’indeterminatezza dello spazio in sé.
Possiamo dunque dire che cosa eravamo e se eravamo qualcosa prima della Di-partizione? No, la Di-partizione, originaria, è, insieme, Autoctisi dell’Io. Come, non abbiamo forse detto che la morte si fa incontro al vivente attraverso la morte dell’altro che non è più e che dunque, prima, era? Questo non significa forse che, in questo farsi incontro, si fa incontro a qualcosa che già c’è, a un individuo già lì essente, vivo, come vivo ed essente era l’altro da colui che permane, prima del suo di-partirsi da sé e dall’essere? Come può qualcosa farsi incontro al Ni-ente?
Noi abbiamo detto questo, questa è la nostra prospettiva, non è la prospettiva di
quel vivente. Quel vivente, prima d’evento della Di-partizione, non è alcunché, neppure un vivente, giacché il vivente è un non-morto, ossia è al di qua della Di-partizione. L’edificio dell’Io è un orizzonte intrascendibile che condanna all’immediata contraddizione ogni
affermazione o
predicazione circa l’esserci di qualcosa oltre esso.
Bene, se la Di-partizione è l’evento originario, Io, che vedo l’altro morire e che comprendo – nell’ontogenesi o quale individuale datità empirica – in quell’attimo il mio essere ancora vivo e dunque il mio semplicemente essere qualcosa nel non essere l’altro da me che non è più, significa che sono già oltre l’evento della Di-partizione?
Destinalmente sì. Non dobbiamo infatti pensare che tra l’evento dell’Originario o Destino e la manifestazione dell’evento dell’Originario nella Storia non si dia Dif-ferenza, non si dis-chiuda Iato. Il Destino, infatti, è Storia, ovvero dispiegamento della struttura endiadica del sé.
La Di-partizione, piuttosto, è costitutivamente o essenzialmente Prolessi, Anticipazione, Escatia, Ultimità.
Ecco che la prima manifestazione storica o deittica della Di-partizione trascendentale apre quel tempo mitico primordiale che precede la sorgenza dell’ontologia greca.
Qui, il principio prolettico è proletticamente. La Contraddizione, contraddittoriamente. Qui dunque l’uomo inizia a morire, e dunque a vivere, ma vive avvolto dal dubbio, il suo esserci è incerto poiché la Storia dell’Essere o il disvolgimento apofatico o contraddittorio del Destino in sé Contraddizione o Non-essere-ente-alcuno, egualmente la teoria della contraddittorietà del Contraddittorio, ancora lascia libero spazio all’evenire di qualcosa, e la possibilità che ci sia qualcosa è dubbio, è il dubbio che ciò a cui mi afferro sia instabile, sogno e ombra vana.
Ma l’uomo vuole vivere con certezza assoluta, come detto, scacciare con Verità la morte, il Nulla. Sorge dunque il tempo dell’Eterno, del Necessario, dell’Incontraddittorio. L’uomo ora o, piuttosto, l’Io, non muore più, muore solo il suo corpo, la sua anima è eterna, come visto nel dischiudimento diadico platonico. Ma il tempo dell’Incontraddittorio-in-sé non è il tempo dell’incontraddittorietà dello stare del Contraddittorio originario, bensì il contro-tempo o tempo deuteriore in cui l’Originario – votato, ricordiamo, all’impressione d’incontraddittorietà al proprio stare in principio per necessità prolettico o contraddittorio, ipotetico (precisamente essendo Pro-lessi o Di-partizione il contenuto dell’adunazione originaria, non ha, in principio, entro sé, l’incontraddittorietà, né può averla se non come elenchicamente incontraddittoria destinazione all’estrema sua conquista attraverso l’ex-pressione di contraddittorietà al sé o im-pressione di incontraddittorietà all’altro da sé tutto) – procede oltre l’adunazione originaria dell’in-sé Di-versione, pro-cede ovvero verso l’adunazione dell’Adunazione in sé o tempo dell’Identità, dell’Essere, dell’Eterno, che taluni chiamano epoca apollinea, quando ovvero l’Aduzione-in-sé seconda sta coerentemente o incontraddittoriamente (per contro-necessità, se l’Originario in sé Contraddizione in principio non può non stare se non contraddittoriamente, avendo l’incontraddittorietà fuori di sé, come suo destino di costruzione storica [è precisamente questa l’identità originaria, costruzione dell’identità attraverso l’edificazione completa dell’altro da sé, cioè di ogni identità che non sia, in sé, Alterità-da-tutte-le-identità], come destino di impressione asintotica d’incontraddittorietà ultima, il Deuteriore in sé Incontraddittorietà in principio non può non stare se non incontraddittoriamente).
Ma l’eterno è l’assente da Di-partizione alcuna: ecco che, sul piano della Storia, l’uomo, per evitare la morte, comprende di aver sacrificato l’Io: nell’eterno, Io non sono Io, epperò, se Tutto è, Io non sono alcunché.
Sul piano del Destino, ovvero sul piano della configurazione ontologica in cui l’uomo è gettato, e possiamo adesso chiamare Epocalità questo piano, l’Eterno deuteriore, stando co-erentemente all’insé, ovvero come Coerenza o Identità, satura ogni latenza della contraddittorietà del Contraddittorio, ovvero chiude ogni possibilità alla storia apofatica del Contraddittorio o Non-essere di essere ancora qualcosa di diverso da ciò che, lì e allora, è: se il contraddittorio è pieno, completo, continuo “ché ente a ente accostasi” (Parmenide), niente di diverso da ciò che già è può ancora essere.
E, nondimeno, l’Incontraddittorio non può essere la configurazione ultima, non essendo l’originaria. Ecco che lo stare dell’incontraddittorio in sé o adunazione seconda inizia a divenire contraddittorio: tramonta l’epoca dell’episteme, dell’eterno, del Dio, della verità. Ogni posizione è provvisoria, naufragabile. Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso. Questo è precisamente il tempo che stiamo attraversando, il tempo della distruzione degli immutabili. Possiamo chiamare questo contro-tempo del Deuteriore epoca faustiana.
Come, Faust non vive in perenne protensione verso l’Eterno? Certo, attraversiamo ancora, infatti, il tempo dell’eterno, nel suo controtempo, s’è detto. Ma l’eterno gotico, possiamo anche definirlo, filosoficamente, l’eterno del pensiero fichtiano, è forse l’eterno stare, l’eterno essere, o non piuttosto l’eterno divenire verso l’eterno, il
compito eterno? (Dunque non l’eterno divenire dei greci, che propriamente è un eterno stare perché manca della dimensione della profondità: oscillare eternamente tra A e B senza mai ultra-incedere in C, non è avanzare verso qualcosa, bensì stare, uno stare dinamico se si preferisce, ma comunque uno stare, un essere).
Ma, cosa significa il
Sollen del perenne divenire verso l’eterno se non giàl’eterno distruggere ogni limite finito verso l’Illimite? Il controtempo dell’epoca deuteriore è precisamente questo spostarsi dell’Eterno dallo stare al tendere, tendere che ha lo stare come limite e l’iconoclastia di ogni stare e di ogni limite come modo d’essere. L’eterno è ora l’eterno distruggere ogni stare eterno.
Come muore, dunque, in conclusione, l’uomo nell’epoca faustiana, l’uomo del nostro tempo? Non può morire come nel tempo apollineo, confidando nell’eternità del suo essere, poiché l’eterno, per Faust, è un punto di tensione irraggiungibile e il suo essere è destinato al nulla. Ebbene,
può proporsi il compito di non morire. Ovvero considera la morte come uno di quei limiti che è suo compito o
sollen abbattere. Ecco che noi ricerchiamo non la vita eterna dopo la morte, ma la vita eterna in vita.
Ma, infine, ricordiamoci che la tensione oltre ogni limite di Faust ipostatizza quella configurazione storica che è speculare, nella vicenda del Destino, alla distruzione della posizione d’incontraddittorietà dell’Incontraddittorio secondo, penultima posizione ante l’avvento della posizione d’incontraddittorietà del Contraddittorio originario.
Pertanto, il tempo di Faust e dei suoi miraggi di vita eterna ottenuta attraverso la tecnica non può essere l’ultima corresponsione dell’uomo all’evento originario della morte o Di-partizione prima o trascendentale.
Concluso epperò il tempo dello stare contraddittorio dell’Incontraddittorio secondo, e questo nostro tempo sarà concluso, raggiungerà ovvero la propria pienezza entelechiale, nella distruzione completa dell’Incontraddittorietà, ovvero di ogni limite distintivo, da ultimo distruggendo il limite da Uomo-e-Non-Uomo, sorgerà il tempo dello stare incontraddittorio della Contraddittorietà originaria, il tempo dell’adempimento della Prolessi archea.
Come, dunque, vivrà e morirà l’uomo nel tempo storico o diurno della posizione d’incontraddittorietà del Contraddittorio, ovvero nel tempo dell’entelechia della Notte destinale?
Rispondiamo heideggeriamente con un domandare: può il Contraddittorio
essere incontraddittoriamente, essere incontraddittoriamente ed essere?
Grazie.
 Argomenti
Annali Faustiani
Diurnalia
Opere
Autori
Antologia filosofica del '900
Prospettiva Russia
Rivoluzione Conservatrice
Argomenti
Annali Faustiani
Diurnalia
Opere
Autori
Antologia filosofica del '900
Prospettiva Russia
Rivoluzione Conservatrice


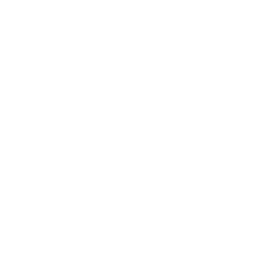
 Argomenti
Annali Faustiani
Diurnalia
Opere
Autori
Antologia filosofica del '900
Prospettiva Russia
Rivoluzione Conservatrice
Argomenti
Annali Faustiani
Diurnalia
Opere
Autori
Antologia filosofica del '900
Prospettiva Russia
Rivoluzione Conservatrice